A cura di don Massimo Lapponi e Bernardino Manzocchi.
Con il capitolo 20 intitolato “Riverenza nella preghiera” si chiude questo manuale liturgico contenuto nella Regola di San Benedetto. Offre anch’esso importanti insegnamenti che sono strettamente legati alla tradizione cristiana e alla liturgia cattolica nelle sue forme più antiche. La preghiera è un atto di umiltà e devozione davanti a Dio. La Regola di San Benedetto è particolarmente significativa per la Liturgia delle Ore. La struttura delle Ore Canoniche richiede preghiere brevi e frequenti, seguendo l’ideale benedettino di preghiere “brevi e pure”. La ripetizione di salmi e orazioni nel Breviario Romano è un riflesso di questa tradizione di preghiera continua e disciplinata. Questa visione della preghiera è intimamente legata alla tradizione cristiana e trova un’espressione concreta nella liturgia cattolica antica. L’accento sull’umiltà, la purezza del cuore, la brevità e la comunità sono valori che sono centrali nella pratica liturgica e nella vita spirituale dei fedeli. La Messa, con la sua ricchezza di gesti e preghiere, è un esempio di come questi principi siano stati integrati e preservati nella tradizione della Chiesa.
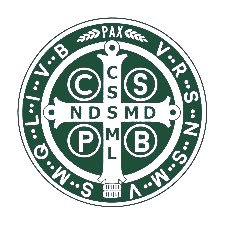
Il capitolo comincia con una comparazione tra la richiesta di favori a grandi personaggi e la supplica a Dio. Questa analogia sottolinea l’importanza dell’umiltà e del rispetto nella preghiera. In un contesto liturgico, questo atteggiamento è evidente nelle posture di riverenza come il genuflettersi e l’inchinarsi, pratiche comuni nella liturgia tridentina. Queste posture sono espressioni esteriori di un’interiore disposizione di umiltà e adorazione.
L’efficacia della preghiera non dipende dalla quantità di parole, ma dalla purezza del cuore e dalla compunzione. Questo riflette l’insegnamento evangelico di Gesù nel Vangelo di Matteo (6,7-8), dove Gesù rinnega la preghiera parolaia che invece è propria dei i pagani, i quali credono che verranno esauditi per la loro prolissità. Nella liturgia antica, questo principio si manifesta nella struttura delle preghiere, che sono spesso brevi, concise e altamente simboliche. Ad esempio, la preghiera del “Confiteor” all’inizio della Messa Tridentina è un esempio di come la Chiesa incoraggia una sincera confessione di peccati con parole misurate, accompagnate da gesti di pentimento.
San Benedetto raccomanda che la preghiera personale sia breve, a meno che non sia prolungata per ispirazione divina, e che nella comunità, al segnale del superiore, tutti si alzino. Questo evidenzia il valore della disciplina e dell’ordine nella vita monastica, che riflette l’ordine liturgico e comunitario della Chiesa. Nella Messa Tridentina, i movimenti e le azioni del sacerdote e dei fedeli sono strettamente regolati, contribuendo a un’esperienza di preghiera comunitaria che è ordinata e unificata.
Le pratiche di preghiera strutturate e disciplinate rispondono a bisogni umani fondamentali di ordine, comunità e trascendenza e rendono presente in forma in qualche modo tangibile il mondo soprannaturale che misticamente avvolge e domina il mondo profano che gli uomini si illudono di avere sotto il loro totale controllo. L’enfasi sulla brevità e purezza della preghiera riflette una comprensione profonda della psicologia umana, riconoscendo che la vera comunicazione spirituale è più efficace quando è concisa e sincera. La dimensione comunitaria della preghiera, regolata dal segnale del superiore, sottolinea l’importanza della coesione sociale e dell’identità collettiva, elementi essenziali per la stabilità e il benessere di una comunità monastica. Questi aspetti evidenziano come le pratiche religiose siano intimamente connesse ai bisogni e alle dinamiche sociali degli esseri umani.
Capitolo 20 della Regola di San Benedetto.
Quando vogliamo ottenere un favore dai grandi personaggi, osiamo chiederlo solo con umiltà e rispetto; tanto più umilmente e devotamente dobbiamo supplicare Dio, Signore dell’universo.
Sappiamo poi di essere esauditi non per l’abbondanza delle parole, ma per la purezza del cuore e la compunzione delle lacrime. Perciò la preghiera sia breve e pura, a meno che non la si prolunghi per una ispirazione della grazia divina.
Ma in comunità, la preghiera personale sia brevissima e, al segnale del superiore, tutti si alzino.
Traduzione a cura della comunità dell’abbazia di Noci

Rinnovamento Benedettino

Centro Teologico BENEdettino Blog
ctbene.wordpress.com
